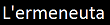«Se un uomo in sogno attraversasse il Paradiso e gli dessero un fiore come prova d’esserci stato, e al risveglio si trovasse con quel fiore in mano… e allora?»
(Samuel Taylor Coleridge)
Passeggiavo al crepuscolo per le strade deserte di una città barocca del Centro America, in compagnia di un uomo che mi faceva da guida. Mi chiesi dove fossi. Sebbene il luogo mi risultasse familiare, ebbi la sensazione, per qualche inspiegabile motivo, di trovarmi a Città del Messico. Era un tiepido pomeriggio di fine settembre dei primi anni Cinquanta.
Salivamo lentamente lungo la via principale, avvolti in un silenzio irreale. Non c’era nessun altro oltre a noi due. La strada era rivestita di ampie lastre di calcare lucido e compatto del color del miele. Ai lati si intravedevano i solchi lasciati dalle ruote dei carri che un tempo dovevano avere risuonato per quelle vie ora silenziose.
La luce calda e dorata di quel che rimaneva del giorno si attardava ancora sulle facciate dei palazzi, impreziosite da sontuosi balconi barocchi sui quali i miei occhi indugiavano affascinati, rapiti dalla vaporosa eleganza delle curve morbide e sinuose delle ringhiere in ferro battuto che si espandevano leggere nell’aria, esuberanti e sensuali come gonne gonfiate dal vento.
Un eterno gioco della seduzione che contrastava con l’enigmatica ieraticità dei mascheroni scultorei che decoravano la parte inferiore delle mensole. Figure antropomorfe e grottesche, custodi di segreti inaccessibili, guardiani imperscrutabili che ponevano domande alle quali era arduo rispondere.
Il riverbero giallognolo dei primi lampioni accesi proiettava lunghe ombre nere sulle facciate dei palazzi, disegnando arabeschi indecifrabili e misteriosi nei quali mi smarrii. Ombre che deformavano ancor più i volti ghignanti delle sculture, accentuandone il carattere inquisitorio e minaccioso.
L’uomo che era con me percepì il mio turbamento. Poggiò la mano sulla mia spalla e mi trasse a sé, distogliendomi da quella visione che mi inquietava. Mi girai verso di lui. I lineamenti del suo viso erano sottili, gli occhi scuri e profondi. Credetti di riconoscerlo. Era un volto antico e familiare che per troppo tempo avevo ignorato e che adesso riemergeva dalle nebbie dell’oblio. L’uomo mi sorrise. Poi, con un gesto lento e rassicurante, indicò la strada davanti a noi e proseguimmo il cammino.
Giungemmo nei pressi di un grande palazzo nobiliare dalla facciata imponente che sorgeva nella parte più alta e antica della città, di fronte alla vallata del grande fiume. Guardai giù nella valle e vidi brillare mille luci. Credetti di orientarmi e di riconoscere il luogo.
Nel cielo filari di nuvole sfilacciate accendevano di cremisi l’orizzonte. A occidente le colline già si annerivano, per sfumare nell’oscurità della notte che di lì a poco sarebbe sopraggiunta.
Il palazzo si affacciava su una piazza silenziosa, di una bellezza antica e riservata, al centro della quale sorgeva una grande fontana. Mi avvicinai a essa, attratto dallo scrosciare dell’acqua che risuonava cristallina nel grande silenzio. Una brezza leggera saliva dalla valle. Mi bagnai le mani e il viso. L’acqua era fresca e limpida. Poi tornai dalla mia guida che era rimasta ad attendermi poco lontano e ci avvicinammo al palazzo. Il portone era socchiuso. L’uomo mi fece cenno di entrare.
(continua)
 (Nella foto: Palazzo Cosentini, Ragusa Ibla)
(Nella foto: Palazzo Cosentini, Ragusa Ibla)