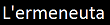27 giugno 2011- lunedì – Waternish e Duirinish
Mi sveglio alle sette, apro le tende e scopro che c’è uno splendido sole. Il paesaggio sotto la luce del mattino sembra completamente diverso rispetto al giorno precedente. Poco prima delle dieci parto per la penisola del Waternish e Duirinish, sulla costa occidentale, a circa 40 miglia da Portree.
Percorro la strada A87 per una decina di miglia e poi imbocco la A850 per Dunvegan. A metà strada, all’altezza del Fairy Bridge – il piccolo ponte dove secondo la leggenda, la moglie del capoclan dei Macleod abbandonò per sempre il marito e i figli per ritornare al suo magico mondo di fate – prendo la stradina “single track” B886 che conduce alla penisola del Waternish. Casette e cottage bianchi costeggiano la strada che conduce al mare. Sui prati, vicino alle case, decine di pecore e mucche con i loro agnelli e vitelli pascolano tranquille.

 Dopo una decina di minuti mi trovo di fronte ad una splendida baia con le isole Ascrib sullo sfondo. Poco più avanti, ad un bivio isolato, imbocco la stradina che conduce a Geary. Il paesaggio è meraviglioso, la stradina si snoda attraverso morbide colline di un verde brillante, sotto un cielo straordinariamente terso e azzurro, ravvivato da bianchissime nuvole mosse dal vento. Le case si fanno più rade, così come la presenza umana.
Dopo una decina di minuti mi trovo di fronte ad una splendida baia con le isole Ascrib sullo sfondo. Poco più avanti, ad un bivio isolato, imbocco la stradina che conduce a Geary. Il paesaggio è meraviglioso, la stradina si snoda attraverso morbide colline di un verde brillante, sotto un cielo straordinariamente terso e azzurro, ravvivato da bianchissime nuvole mosse dal vento. Le case si fanno più rade, così come la presenza umana.


 Dopo l’ennesima curva, mi si para davanti, inaspettata e quasi irreale nella sua scenografica evidenza, una stradina lunga e dritta che taglia in due il verde della collina dividendola in parti speculari.
Dopo l’ennesima curva, mi si para davanti, inaspettata e quasi irreale nella sua scenografica evidenza, una stradina lunga e dritta che taglia in due il verde della collina dividendola in parti speculari.
È la strada che conduce alle rovine della chiesa di Trumpan e al suo piccolo cimitero, sulla sommità di un promontorio. Sullo sfondo, il mare, onnipresente. Ho come la sensazione di essere giunto alla fine del mondo. Parcheggio l’auto in un piccolo spiazzo adiacente alla chiesa. Ci sono solo cinque turisti che poco dopo se ne vanno.
 Entro nel prato recintato dove sorgono le rovine dell’antica chiesa di Trumpan e un piccolo cimitero che sembra uscito da un romanzo gotico.
Entro nel prato recintato dove sorgono le rovine dell’antica chiesa di Trumpan e un piccolo cimitero che sembra uscito da un romanzo gotico.
La chiesa di Trumpan fu teatro di due sanguinosi massacri maturati nello stesso giorno, una domenica di maggio del 1578, nell’eterna lotta fra i due clan rivali che si contendevano il controllo dell’isola, i MacLeod e i MacDonalds.
Quel giorno i MacDonalds arrivarono da Uist via mare nella baia di Ardmore, sotto Trumpan. Protetti da una spessa coltre di nebbia riuscirono a sbarcare senza essere notati e assediarono la popolazione che fu costretta a rifugiarsi nell’area della chiesa. In cerca di vendetta per il precedente massacro di Eigg, i MacDonalds diedero fuoco al tetto di legno della chiesa dove aveva cercato rifugio la gente del posto.
Fu una strage tremenda. Morirono tutti soffocati o bruciati, tranne una ragazzina che riuscì a fuggire attraverso una strettissima finestra di pietra, che ancora oggi si può vedere, mutilandosi un seno nella fuga, e riuscendo poi a dare l’allarme.
Gli uomini del clan dei MacLeod arrivarono in brevissimo tempo da Dunvegan, da dove le fiamme dell’incendio della chiesa erano ben visibili, e non diedero scampo ai MacDonalds. Si impadronirono delle loro navi ormeggiate nella baia, e poi li attaccarono di sorpresa uccidendoli quasi tutti. Alla fine gettarono i cadaveri e i feriti in una cava di tufo poco distante tumulandola con un’enorme lastra di pietra.
Immerso in queste storie terribili di cui sembra di percepire ancora l’eco nell’aria, mi aggiro fra le lapidi del cimitero leggendo i nomi dei morti e le dediche dei loro familiari, in inglese e gaelico.
 Croci celtiche si innalzano un po’ ovunque. Sono completamente da solo nel cimitero, unica presenza viva in quel luogo. Camminare nel silenzio, fra quelle lapidi che fronteggiano il mare in uno scenario così grandioso, con solamente il suono del vento nelle orecchie e il ricordo di quel tragico passato di sangue, sembra annullare di colpo le distanze temporali, come se tutto fosse un eterno presente, un unico attimo immenso. Mi sembra di sentire vive attorno a me le presenze di quelle persone, seppellite nella terra in cui sono sempre vissute e da cui non si sono mai allontanate. Un grande senso di pace mi pervade. Percepisco dentro di me l’incessante divenire e fluire di tutte le cose nel ciclo della natura. Come se il mio mondo interiore si ampliasse e si estendesse fino a comprendere e inglobare l’intero universo, fino a diventare tutt’uno con il mondo esterno. Una sorta di ebbrezza panica.
Croci celtiche si innalzano un po’ ovunque. Sono completamente da solo nel cimitero, unica presenza viva in quel luogo. Camminare nel silenzio, fra quelle lapidi che fronteggiano il mare in uno scenario così grandioso, con solamente il suono del vento nelle orecchie e il ricordo di quel tragico passato di sangue, sembra annullare di colpo le distanze temporali, come se tutto fosse un eterno presente, un unico attimo immenso. Mi sembra di sentire vive attorno a me le presenze di quelle persone, seppellite nella terra in cui sono sempre vissute e da cui non si sono mai allontanate. Un grande senso di pace mi pervade. Percepisco dentro di me l’incessante divenire e fluire di tutte le cose nel ciclo della natura. Come se il mio mondo interiore si ampliasse e si estendesse fino a comprendere e inglobare l’intero universo, fino a diventare tutt’uno con il mondo esterno. Una sorta di ebbrezza panica.
All’improvviso una turista entra nel parco e mi riporta alla realtà. Esco e mi dirigo verso il promontorio e la baia dove cinque secoli prima approdarono le navi dei MacDonald, a circa due miglia e mezzo di distanza. Il sentiero è seminascosto dall’erba alta, bisogna scavalcare dei muretti e attraversare cancelletti e recinzioni. Un’anziana coppia con due cani mi precede. Alla fine della discesa arrivo alla spiaggia, interamente ricoperta di sassi e rocce. I vecchietti rallentano e si fermano a riprendere fiato. Li supero.

 Mi dirigo da solo verso la salita che conduce alla sommità del promontorio. Arrivo in cima. Sono quasi stordito dal verde brillante dell’erba, dall’azzurro puro del cielo, dal blu scuro e intenso dell’oceano: solo il vento e le urla dei gabbiani sopra di me. L’aria è fresca, inebriante. Oltre il promontorio c’è un’altra piccola baia con dei faraglioni a picco sul mare e poco lontano delle rovine di vecchi stabilimenti manifatturieri. Mi dirigo verso i faraglioni.
Mi dirigo da solo verso la salita che conduce alla sommità del promontorio. Arrivo in cima. Sono quasi stordito dal verde brillante dell’erba, dall’azzurro puro del cielo, dal blu scuro e intenso dell’oceano: solo il vento e le urla dei gabbiani sopra di me. L’aria è fresca, inebriante. Oltre il promontorio c’è un’altra piccola baia con dei faraglioni a picco sul mare e poco lontano delle rovine di vecchi stabilimenti manifatturieri. Mi dirigo verso i faraglioni.

 Scrutando l’orizzonte mi accorgo che sono completamente solo nel raggio di alcune miglia. Attorno a me non c’è alcuna presenza umana. Da un lato l’oceano, dall’altro la sconfinata campagna che si estende a perdita d’occhio. Alcune mucche pascolano lontane, quasi indistinguibili dal resto del paesaggio. Provo una strana sensazione. Non sento solitudine o paura. Mi sento in perfetta armonia con la natura incontaminata che mi circonda. Una sensazione di euforia fisica e psichica, di ebbrezza mi pervade.
Scrutando l’orizzonte mi accorgo che sono completamente solo nel raggio di alcune miglia. Attorno a me non c’è alcuna presenza umana. Da un lato l’oceano, dall’altro la sconfinata campagna che si estende a perdita d’occhio. Alcune mucche pascolano lontane, quasi indistinguibili dal resto del paesaggio. Provo una strana sensazione. Non sento solitudine o paura. Mi sento in perfetta armonia con la natura incontaminata che mi circonda. Una sensazione di euforia fisica e psichica, di ebbrezza mi pervade.
Arrivo fino alle rovine, scatto un po’ di fotografie e poi decido di ripartire, ripercorrendo a ritroso la strada che avevo fatto precedentemente. Alla fine, quando verso le due arrivo all’auto, avverto la stanchezza. Complessivamente avrò fatto più di due ore di marcia difficoltosa in salita, fra i prati e le rocce delle scogliere.
Riparto per il castello di Dunvegan e la penisola del Duirinish, diretto a Neist Point e il suo faro.
Mi lascio Trumpan e i suoi grandi spazi disabitati alle spalle e dopo una ventina di minuti mi ritrovo in un paesaggio radicalmente diverso. Ci sono residenze signorili e lussuose con giardini bellissimi.
Poco prima di arrivare al castello, mi fermo nei pressi di un’antica chiesa diroccata, la St. Mary’s Church e il suo bellissimo giardino. Le rovine della chiesa sorgono su un’area che fino a prima dell’anno Mille era luogo di culto dei riti celtici. Le rovine sono molto pittoresche, emanano un fascino gotico ricco di mistero. Si percepisce quel senso del “sublime” che nacque proprio in Inghilterra e in Scozia alla fine del Settecento.



 Dopo un po’ riparto e arrivo al famoso castello di Dunvegan, ma non entro. Troppo affollato di visitatori, decine di pullman carichi di turisti anziani. Non fa per me. Compro dei pupazzetti di peluche per le bambine e riparto. Sono le tre del pomeriggio. Mi dirigo verso Neist Point, all’estremità occidentale dell’isola.
Dopo un po’ riparto e arrivo al famoso castello di Dunvegan, ma non entro. Troppo affollato di visitatori, decine di pullman carichi di turisti anziani. Non fa per me. Compro dei pupazzetti di peluche per le bambine e riparto. Sono le tre del pomeriggio. Mi dirigo verso Neist Point, all’estremità occidentale dell’isola.
Imbocco una stradina “single track” che attraversa un paesaggio spettacolare. A un certo punto incontro un bivio che indica due direzioni opposte, Orbost e Glendale, due località non compaiono nella mia pur dettagliata mappa. Sono lì da solo, nel mezzo del nulla. E non c’è nessun’anima viva a cui chiedere. Decido di tirare a sorte, orientandomi a intuito, e vado dritto.
 La strada, strettissima, attraversa un paesaggio brullo e vulcanico, dominato dalla mole delle Red Hills. Dopo un po’ il paesaggio diventa più dolce, un ruscello scorre nella campagna e lungo il suo percorso alcune mucche e pecore pascolano tranquille.
La strada, strettissima, attraversa un paesaggio brullo e vulcanico, dominato dalla mole delle Red Hills. Dopo un po’ il paesaggio diventa più dolce, un ruscello scorre nella campagna e lungo il suo percorso alcune mucche e pecore pascolano tranquille.
 A un certo punto la strada termina nello spiazzo di una fattoria. Sono arrivato a Orbost, un borgo di poche case e abitazioni rurali. Alcuni bambini biondi giocano a rincorrersi nel grande spiazzo. I loro capelli risplendono come oro nella controluce. Poco più in là, dei panni stesi ad asciugare al sole vengono gonfiati dal vento. Due uomini armeggiano attorno a un trattore. Mi fermo e chiedo quale sia la strada per Neist Point. Mi rispondono con un forte accento scozzese, dicendomi che la strada giusta era quella che andava nella direzione opposta. Li ringrazio, lascio quell’oasi di vita agreste d’altri tempi e ritorno indietro sulla mia strada.
A un certo punto la strada termina nello spiazzo di una fattoria. Sono arrivato a Orbost, un borgo di poche case e abitazioni rurali. Alcuni bambini biondi giocano a rincorrersi nel grande spiazzo. I loro capelli risplendono come oro nella controluce. Poco più in là, dei panni stesi ad asciugare al sole vengono gonfiati dal vento. Due uomini armeggiano attorno a un trattore. Mi fermo e chiedo quale sia la strada per Neist Point. Mi rispondono con un forte accento scozzese, dicendomi che la strada giusta era quella che andava nella direzione opposta. Li ringrazio, lascio quell’oasi di vita agreste d’altri tempi e ritorno indietro sulla mia strada.
Ad un certo punto, nel tratto in cui la strada è più stretta e si fa fatica a credere che ci possa passare una macchina, figurarsi due, ecco apparire un’altra auto all’orizzonte. Si ferma ma non accosta. Mi accorgo che vicino a me non ci sono piazzole dove accostare, se non una cinquantina di metri dietro. Fare marcia indietro con la guida a sinistra su una stradina strettissima, senza bordi e cordoli, con un metro di dislivello da entrambi i lati è veramente impegnativo. Mi sembra di essere tornato ragazzo quando dovevo imparare a guidare. Il rischio di uscire fuori di strada è molto alto. Ma l’altra automobile non si muove, rimane lì, inchiodata sulla strada. Mi accorgo allora che alla guida c’è una vecchina dai capelli bianchi. Ci fronteggiamo per alcuni istanti, immobili, sotto il sole, come i duellanti in un film western di Sergio Leone.
Provo a fare marcia indietro, ma è un disastro. Non ho il pieno controllo dell’auto. Non riesco a fare retromarcia se non zigzagando, un po’ a destra, un po’ a sinistra. Una manovra che in Italia avrei fatto ad occhi chiusi e in pochi secondi qui è diventata una missione quasi impossibile. Per alcuni istanti considero pure la vigliacca, ma molto umana, ipotesi di scendere dall’auto, andare dalla vecchia e implorarla di fare marcia indietro dicendo che sono un povero italiano che guida a sinistra solo da due giorni. Ma poi, non so bene se per orgoglio o incoscienza, mi decido a fare quei 50 metri di marcia indietro. Vado lentissimo. Più volte devo ingranare nuovamente la prima e andare un po’ avanti e poi di nuovo indietro per riportare l’auto in carreggiata, evitando di farla uscire di strada. Sudo le proverbiali sette camicie. Alla fine ce la faccio. Arrivo alla piazzola: mi sento come un naufrago che dopo una lunga nuotata fra i marosi arriva stremato alla riva. Ormai in salvo, faccio cenno lampeggiando con gli abbaglianti alla vecchina che sino a quel momento è rimasta immobile a guardare la scena. Finalmente si muove, si avvicina, mi affianca e mi saluta con un cenno della mano e un sorriso ineffabile ed enigmatico. Anch’io la saluto con un cenno della mano, mentre interiormente la mando a quel paese in tutte le lingue che conosco. Sono un bagno di sudore. Non avevo mai contemplato così da vicino la possibilità di finire fuori strada con l’auto ribaltata.
Riparto in direzione della penisola di Duirnish, prendendo la strada per Glendale. Finalmente trovo l’indicazione per Neist Point. La stradina è ancora più stretta di quella precedente, si inerpica tortuosa salendo in cima con una pendenza molto ripida.
Procedo molto lentamente. Ogni tanto quando arriva qualche auto nel senso opposto, memore dell’esperienza precedente, accosto e mi fermo del tutto. Ai lati della stradina stavolta non ho un dislivello di pochi metri, ma un vero precipizio di una cinquantina di metri sulle rocce e sul mare.
Finalmente arrivo al promontorio di Neist Point. Parcheggio e arrivo fino al punto da cui parte il sentiero che dalla cima della collina conduce giù fino al faro. La vista mozza il fiato. C’è un vento fortissimo. A quel punto mi rendo conto che non posso fare il sentiero a piedi quel giorno. Ci vorrà almeno un’ora solo per l’andata e sono già le cinque del pomeriggio, devo ancora tornare a Portree.

 Decido di ritornarci due giorni dopo, di mattina, quando il sole sarà alle spalle e le condizioni di luce saranno ideali per fotografare. Riparto poco dopo le cinque. Ci metto 35 minuti a fare le 10 miglia di stradina tortuosa “single track” e un’altra mezz’ora a fare le 25 miglia fino a Portree.
Decido di ritornarci due giorni dopo, di mattina, quando il sole sarà alle spalle e le condizioni di luce saranno ideali per fotografare. Riparto poco dopo le cinque. Ci metto 35 minuti a fare le 10 miglia di stradina tortuosa “single track” e un’altra mezz’ora a fare le 25 miglia fino a Portree.
Quando arrivo a casa sono esausto. Mi accorgo che ho il viso arrossato per il sole. Durante la lunga scarpinata del mattino, esposto al sole fra le scogliere di fronte al mare, mi sono abbronzato senza nemmeno accorgermene.
Faccio una doccia calda e rilassante. Poi la sera esco e vado a cena al “Sea Breezes”, un ristorante di mare molto caratteristico nella zona del porticciolo di Portree. All’uscita c’è ancora luce e prima di tornare a casa mi soffermo a fare delle foto ai pescherecci ormeggiati al porto.